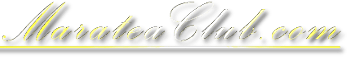Sopra la chiesa il tempio campa, sotto la chiesa il tempio crepa
Tutti gli appassionati di storia locale hanno sentito dire che la chiesa di S. Biagio sarebbe sorta su un tempio pagano dedicato a Minerva. Addirittura, la montagna si sarebbe chiamata, nell’antichità, Monte Minerva. Com’è nata tradizione?
La tradizione della “Dea del Mare”.
Prima di approfondire la questione del tempio, dobbiamo fare una premessa. Per comprendere il contesto, dobbiamo ricordare che, almeno a partire dalla fine del Seicento, gli scrittori marateoti diedero avvio alla tradizione storiografica secondo cui Maratea sarebbe nata all’epoca della colonizzazione della Magna Grecia.
La prima traccia di questa tradizione si trova in un’opera teatrale. Si intitolava Il Trionfo della Fede o il Martirio di S. Biase, scritto alla fine del XVII o all’inizio del XVIII secolo da un poeta marateota di cui non è stato perpetrato il nome. Dell’opera sopravvivono solo dodici versi della quattordicesima scena del primo atto, trascritti nel 1723 dal parroco Gaetano Ventapane (1695-1745). Dicevano:
«Dall’antica Città di Velia distrutta / Poche leghe distante in Riva al Mare Ove al Settentrione termina il Lido / La Calabria felice / Erge sassaso Monte altero il Capo / Quasi à toccar col Sole, à cui rend’ombra / Prima tra gl’altri che le stanno in giro / Coronata di mura ha la cervice / Che fan mobilitade in cui primate / Par che le baci e che l’adori / Onde sembrando ella / la Dea del Mare, Maradea s’appella.»

Il Monte San Biagio visto dal mare.
Possiamo perdonare l’ingenuità etimologica all’anonimo drammaturgo che, in forza della licenza poetica, ha potuto non dirci quale fosse il popolo che battezzasse il proprio paese con un nome metà in una lingua e metà in un’altra.
La fortuna della tradizione.
Oggi gli storici sono portati ad escludere che la comunità e la personalità urbana di Maratea siano nate nell’evo antico. Le ricerche archeologiche condotte sinora sul nostro territorio portano a pensare che l’area insediata, nell’antichità, fosse la costa. Sulla cima del monte le tracce concrete di vita iniziarono solo nel IX o X secolo, all’epoca, cioè, della riconquista bizantina.
Ma la derivazione, seppure parziale, del nome di Maratea dal greco piacque molto ai marateoti colti del Settecento. Giustificava la pretesa di antichità comune a tutte le cittadine del Mezzogiorno, i cui eruditi si inerpicavano nei più svariati voli pindarici per raccontare come il loro paesello nascesse all’epoca della Magna Grecia.
La filiazione di Maratea da Velia, però, non ebbe successo. Forse ai marateoti colti del Settecento dispiaceva l’idea che la loro fosse la figlia d’una città più antica.
Ecco allora arrivare Paolo d’Alitti (1676-1728) un dottore con il pallino della storia. Dalla sua penna uscì il primo libro (o, quantomeno, il più antico giunto sino a noi) sulla storia di Maratea.
«La sua origine, e fondazione è incerta» – scrisse in questo libro – «ma per congetture devesi giudicare antichissima; non essendo credibile, ch’il suo vasto tenimento fosse stato disabitato, e deserto; tanto più essendo marittimo».
Maratea figlia dei (primi) Greci.
A prima vista, il ragionamento non fa una piega. Ma il dottor D’Alitti doveva spiegare perché i fondatori di Maratea scelsero di posizionarla sulla cima d’un monte e non, come tutte le antiche città della Magna Grecia, in riva al mare.

Maratea Castello (foto: Calderano.it)
Chi erano costoro? Perché scelsero quel sito? D’Alitti diede questa risposta:
«Non poterono esser altri, che gli Enotrii, i quali furono i primi Greci, che dall’Arcadia vennero in Italia, dicessette età prima della guerra Troiana, impadronendosi di questi paesi, ove abitavan gli Ausonii»; e tutto ciò «perché gli Enotrii, secondo il loro costume, edificavan le Città in luoghi alti per loro sicurezza, e bontà dell’aere; ed in talmodo edificarono Maratea su l’eminenza del Monte».
I profani potrebbero apprezzare l’ingenua fantasia di D’Alitti che, da buon figlio del suo tempo, datava l’antichità sulla base dei poemi omerici. Ma i conoscitori della storiografia antica avranno riconosciuto il testo da cui D’Alitti attinse: era il libro II delle Ῥωμαϊκὴ Ἀρχαιολογία (Antiquitates Romanae) di Dionigi di Alicarnasso, testo molto in voga alla sua epoca.
In ogni caso, questa versione dell’origine dell’antica Maratea Castello finì col diventare tradizionale. Tutti gli storici locali successivi, fino a tempi recentissimi, la fecero propria.
Il monte Minerva.
La lunga premessa è assolutamente necessaria per comprendere come la tradizione del tempio di Minerva sia nata e abbia potuto prosperare.
L’origine precisa di questa tradizione non è chiara. Il primo accenno pare trovarsi nell’Istoria generale del reame di Napoli scritta da Placido Troyli (1688-1757) e pubblicata nel 1749.
Qui è detto che il monte su cui giaceva Maratea Castello era un tempo «consegrato a Minerva». Quest’antica dedicazione del monte non si trova però in alcuno dei lavori composto da scrittori marateoti nello stesso secolo. Solo nell’Ottocento il parroco Iannini riportò anch’egli che la montagna fosse «un tempo dedicato alla Favolosa Dea Minerva» .
Non è possibile capire se Troyli riportò una tradizione già circolante in Maratea o se piuttosto fu Iannini, che aveva certamente letto l’Istoria (la cita nel suo manoscritto), a inserire nella storiografia locale questo elemento, che Troyli derivò da chissà dove.
Il tempio di Minerva.
Un dato però emerge con chiarezza. Come avranno notato i lettori più attenti, nessuno dei due autori sopracitati legò il nome della montagna alla presenza di un tempio pagano.

Una cartolina del Castello di inizio XX secolo.
Il tempio di Minerva apparve per la prima volta in un volume pubblicato nel 1954 e scritto dal parroco Domenico Damiano (1891-1969).
«Coll’andare del tempo – scrive questo autore – con la trionfale avanzata del Cristianesimo, col progredire della Fede e dell’arte, il sunnominato tempio di Minerva, rimasto già da anni come un gigante condannato all’isolamento, al silenzio e al disfacimento, fece sorgere l’idea di una rinascita, ma… sotto un’altra insegna: sotto il vessillo della Redenzione! La Croce di Cristo già da sei secoli in marcia per il mondo, elevata sugli altari e sulle torri, doveva scintillare anche sulla vetta di questo Monte, sugli avanzi di quel tempio che da pagano diventava cristiano».
Damiano è quindi anche il primo ad affermare che l’antica struttura fu poi riadattata a chiesa cristiana e che proprio questa divenne l’odierno santuario di S. Biagio.
Un incredibile caso.
A prima vista sembrerebbe di trovarci davanti a un esempio di mito stratificato, scaturito nel solco di quella moda storiografica, affermatasi a partire dalla fine del XVII secolo, che riconduceva ogni antichità paesana all’epoca classica o magnogreca e completatosi in tempi molto più recenti, grazie alla bella prosa di un sacerdote che, con un po’ di fantasia, trasformava la storia dell’origine del santuario nell’ennesimo esempio della vittoria del Cristianesimo sul paganesimo.
Eppure, le cose potrebbero essere più complesse e, dal punto di vista della ricerca, ben più interessanti di così.
Secondo gli archeologi, la presenza di un tempio antico sulla cima del monte San Biagio potrebbe essere non solo possibile ma addirittura probabile, poiché spesso che i templi costieri venivano costruiti sulla sommità di monti la cui sagoma costituiva un preciso punto di rifermento per i naviganti . E non c’è solo questo ragionamento a supporto di questa probabilità: nelle vicinanze del santuario, e precisamente durante il restauro dei bastioni superstiti di Maratea Castello, furono rinvenute due monete romane.
L’articolo di Barolini.
Ovviamente pochi rinvenimenti sporadici non dimostrano alcunché riguardo alla presenza di un tempio sulla cima del monte. Ma, tenendo presente questi ritrovamenti, acquista ancor più interesse un passaggio dell’articolo di Antonio Barolini apparso sul Corriere della Sera nel 1968. Il giornalista, che visitò la basilica durante i lavori di restauro di quegli anni, a fianco d’una intervista al parroco Damiano scrisse che «sotto l’attuale tempio di San Biagio esistono una necropoli cristiana con chiesa di culto (probabilmente del secondo o terzo secolo) e i resti di un antecedente tempio pagano, dedicato a Minerva».

Il santuario oggi.
Strano ma vero, questa testimonianza è stata finora completamente ignorata dagli studiosi locali. Senza dubbio ciò è stato dovuto alla difficoltà di recuperare la fonte giornalistica.
Va da sé che se quanto affermato fosse vero, si tratterebbe di una tra le più importanti scoperte sulla storia dello sviluppo del Cristianesimo sul territorio di Maratea e nel golfo di Policastro. Ciononostante, per quanto affascinanti le parole Barolini non bastano a certificare, al di sopra d’ogni dubbio, la reale esistenza del tempio di Minerva. Il giornalista potrebbe aver semplicemente interpretato male le parole del Damiano o averle riportate in maniera fuorviante.
Resta il fatto che la cima del monte finora non è stata oggetto di scavi sistematici, nonostante la sua indubbia valenza archeologica. Soltanto con moderni studi condotti sul campo potremo arrivare a una conclusione inequivocabile sulla questione.