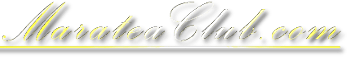Perché noi marateoti amiamo S. Biagio?
Gian Carlo Marchesini, è un amico della nostra Maratea. Ha scritto diversi libri a lei dedicati. Negli scorsi giorni ha pubblicato un pensiero sul sito dell’amico Biagio Calderano, tra le cui righe formula una domanda che si può riassumere con il titolo di questo articolo.
Il moto istintivo è stato provato a dare, prima di tutto a me stesso, una risposta.
1.
La domanda di Marchesini è uno spunto di riflessione non da poco. Non penso sia tale solo per me, ma, credo, un po’ per tutti noi marateoti. Come tutti gli habitué del sito di Biagio, ho sempre letto con piacere le pillole prima e i pensieri poi di Marchesini. So d’esser letto da lui: la cosa mi onora moltissimo.
Rifletterci su non è semplice, perché non è semplice articolare logicamente i sentimenti. Di sentimenti, infatti, si parla ed è giusto parlare quando si tratta cose legate alla fede religiosa, la quale, giusto per esser ancor più complicata delle altre cose, è questione sia intima e privata del singolo, sia pubblica e manifesta per la comunità di cui, anche grazie ad essa, il singolo si sente parte.
Posso comprendere senza giudicar male, come spero chiunque altro, le perplessità di chi di fede religiosa non ha avuto esperienza. Per fortuna del credente e del non-credente, la fede, oltre che sentimento, è anche un fatto sociale e storico, per cui si può indagarne gli aspetti con gli strumenti di quelle scienze.
2.
Partiamo dal fatto storico, cioè l’arrivo delle reliquie di santo armeno in terra lucana. Di storia vera e propria possiamo parlare poco: non ne sappiamo praticamente niente. Come scrisse il primo storico locale che se n’occupò, il D’Alitti, l’unica cosa certa è la traslazione, «riposando il suo corpo in Maratea, ed essendo il Santo morto in Sebaste, ma come e quando sia sortita, n’è incerta l’istoria». Lo scrisse nel 1728. Oggi son passati la bellezza di 295 anni, ma siamo sempre a quel punto: non lo sappiamo.
In questi quasi tre secoli sono circolate (forse) due leggende a sopperire alla mancanza di una storia: la prima, della cui esistenza ho ipotizzato in un piccolo studio del 2020, è quella dell’acquisizione delle reliquie attraverso mercanti. La cosa era piuttosto comune in epoca medievale: la sua degenerazione, la simonia, è piuttosto nota. La seconda, famosissima, è quella della nave che, «co’l mare in calma, e l’aria serena, da incognita remora si conobbe trattenuta, o pure perché turbandosi di repente il mare, non dava luogo a partirsi» (sono ancora parole del D’Alitti), sbarca e consegna le reliquie ai marateoti accorsi dal monte.
La storia, già così, – a mio parere – ha un certo fascino. Caliamoci nel contesto (e quindi sconfiniamo nel sociale). Maratea era un piccolo, e probabilmente miserabile, paese arroccato sulla cima d’un monte prospiciente il mare. La sua origine era umile, tale da non aver interessato alcuno storico antico. (Anzi, nel XVIII secolo gli studiosi locali, pur di dare al proprio paese un posto nella storia antica, si diranno convinti d’esser stata Maratea fondata dai Greci all’epoca della colonizzazione storica: cosa talmente difficile da mandar giù anche alla loro epoca che i colleghi di Napoli proveranno ad associare, com’è noto, Maratea a Blanda.)
3.
Poi, però, la vita di questo paesello fu scossa dall’arrivo di un gruppo di persone (gli armeni portatori delle reliquie) e del loro santo. Non solo un’iniezione di novità nella vita della comunità, ma un appiglio identitario grazie a cui costruire un’intera cultura comune (che potremmo definire, con espressione contemporanea, altamente inclusiva).
Proviamo poi ad aggiungere l’aspetto prettamente religioso. Le reliquie di un santo, venerato da Oriente a Occidente, arrivarono in una terra che santi non ne ha avuti. Cosa significò questo per i credenti dell’epoca? Dovette esser come se il Padre Eterno, comprendendo la lacuna che gli uomini avevano lasciato in quell’angolo di mondo, sopperisse di propria mano, regalando proprio a noi uno dei santi del suo paradiso. Un martire, per giunta, il cui fascino è imperituro nelle epoche.
Luca Mandelli, un agostiniano che descrisse Maratea nella seconda metà del Seicento, scrisse a proposito parole oltremodo esaustive: «l’havere trasportato nella patria il corpo di S. Biase, che in Sebaste d’Armenia havea sofferito il martirio […renderà…] sempre Maratea famosa al mondo non che in questo regno».
4.
E grazie a S. Biagio Maratea divenne famosa e ricca. Prima che al commercio, Maratea dovette la sua fortuna al santo.
Una storia del turismo marateota è ancora da scrivere, ma chi la scriverà dovrà cominciare con la sua preistoria, ovverosia i pellegrinaggi che da ogni dove giungevano a Maratea per rendere omaggio alle reliquie del santo armeno. Nel 1489 toccò nientemeno all’erede al trono di Napoli, il futuro Alfonso II e con il suo entourage. Anche chi aveva una fede diversa porgeva omaggio al santo. Domenico Damiano, parroco del santuario dal 1940 al 1969, in tempo di guerra annotò sul suo diario come «molti ufficiali Anglo-americani si son recati quassù a visitare questo illustre Santuario. Con tutto il rispetto possibile sia i cattolici e sia i “fratelli separati” [anglicani e protestanti, n.d.r.] sono entrati in chiesa, hanno fatto reverenza all’Altare Maggiore, son rimasti pieni di ammirazione dinanzi al Trono del Santo, ed hanno fermata la loro ammirazione su tutto quanto che è antico, di artistico e di altro valore. È inutile dire che essi hanno lasciata la loro generosa offerta al Santo, ed hanno anche fatto acquisto di vari oggetti di devozione e di cartoline illustrate per spedire, stesso qui, nelle loro terre lontane».
Su un piano più materiale, il possesso delle reliquie di S. Biagio fu anche la prima ricchezza economica del paese. Avere un santuario garantiva a una comunità la possibilità, come detto, di ricevere pellegrinaggi, e quindi l’indotto che ne derivava. Un indotto imponente, tanto che nel 1562 papa Pio IV concesse l’indulgenza plenaria a coloro che si recavano a Maratea nella festa di maggio. Festa di maggio che sembrerebbe nel 1428 avesse già ricevuto, dalla regina Giovanna II d’Angiò, il mercato franco, ossia la fiera.
5.
Ricchezza spirituale e materiale si fusero, in un’ottica quasi weberiana, con la prima che generava la seconda grazie a nuove idee ed iniziative: la festa di maggio allungata nel 1695, il teatro comunale (dedicato al santo e aperto forse nel 1696) e nuove opere d’arte, prima tra tutte la statua, cesellata in argento tra il 1699 e il 1706.
In particolare, la statua poi ebbe – ed ha tutt’ora – un ruolo fondamentale. A partire dall’età barocca (e qui torniamo in ambito storico) una statua era quel che ci voleva per una nuova e più potente empatia con la figura del santo, che prima d’ogni altra cosa era un uomo, una persona, proprio come i suoi fedeli.
Il rapporto dei marateoti con la statua di S. Biagio è d’un affetto disarmante, genuino e puro, quasi come quello proprio dei bambini. Gennaro Buraglia, parroco del santuario dal 1855 al 1921, le parlava. Le raccomandava di «farsi leggera» quando andava giù per i festeggiamenti e la sgridava quando «faceva tardi» tornado al Castello. Tutti noi, ancora oggi, abbiamo l’abitudine di «salutare il santo» quando, durante l’anno, saliamo al santuario, o torniamo a casa, nelle serate della festa.
6.
La statua è anche un reliquiario, per cui la dicotomia tra raffigurazione e reliquia è sapientemente elusa. Nella spilla della statua c’è un piccolo frammento della gola del santo. È l’unico pezzo della statua vecchia (quella trafugata nel 1976) sopravvissuto nella nuova: i ladri la lasciarono sull’altare.
Proprio grazie alla presenza di quella spilla, la stessa che da 328 anni è venerata con la statua, io fedele di Maratea mi sento legato fisicamente, e non solo idealmente, a chi mi ha preceduto e a chi mi succederà.
Quando i miei trisavoli non erano ancora nati, i marateoti del passato si ritrovavano ai Muriceddi prima e a Capo Casale poi per aspettare il santo che scendeva tra loro. Quando io sarò cenere nella terra, i marateoti del futuro faranno lo stesso. È un sentimento fortissimo quel che si prova in quel momento, sempre uguale nei suoi tratti essenziali di secolo in secoli: essendoci si elude il tempo e la morte, e si è per un istante immortali in un frammento di eternità.
7.
E quel momento altro non è che una grande teatralizzazione di una storia: un santo che viene da lontano, con altri fedeli, che grazie a lui non sono stranieri ma fratelli, che si uniscono a loro.
È questo, probabilmente, l’aspetto più genuino per il quale noi marateoti amiamo tanto S. Biagio: quella tra noi e lui è una bellissima storia. E di bellissime storie hanno bisogno le nostre vite terrene, le quali altro non sono che
un racconto narrato da un’idiota;
piena di strepito, di furore
e senza alcun significato.
Mi si perdoni la citazione del Bardo, ma quando si deve dire qualcosa d’importante lo si deve far coll’arte, che crea le storie che danno senso al mondo.
A rileggere quanto ho scritto non so se sono riuscito a fornire quel che si cercava; anzi, non sono neppure certo di aver scritto tutto quel che avrei potuto.
Spero che nulla di quel che ho scritto venga colto come un richiamo, anzi: come – sono sicuro – a Marchesini chiedo di esprimere sempre, con l’eleganza e la cultura che gl’è propria, il suo parere, in particolare quando, per così dire, va controcorrente. Perché questo è il compito genuino d’un intellettuale: mettere sempre in discussione e far riflettere sulle basi su cui poggia la società in cui vive (o a cui si sente legato), così da renderla più matura e consapevole.