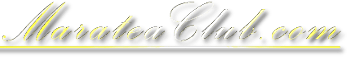Appunti storici sulla chiesetta della Madonna degli Ulivi
C’erano una volta i monaci bizantini…
Quando si parla dell’origine della chiesetta della Madonna degli Ulivi, arroccata dietro la Basilica di San Biagio tra la cima del monte del santo e la roccia della Suda, si è soliti, da qualche decennio a questa parte, collegarsi alla storia dei cosiddetti monaci basiliani, che secondo la più diffusa vulgata sarebbero stati degli eremiti insediatisi nelle nostre terre più di un millennio fa. Questi monaci avrebbero fondato e abitato eremi e grotte per vivere di preghiera, seguendo la regola di S. Basilio il Grande (329-379). Fuggiti dall’Oriente a causa delle persecuzioni iconoclaste, sarebbero approdati in Italia, trovando uno dei luoghi ideali per la loro missione terrena nella nostra Maratea.
In realtà, la storia è un po’ più complicata. Per primo, i monaci basiliani, propriamente detti, non sono mai esistiti: non solo nella Chiesa di Costantinopoli gli ordini religiosi non esistevano, ma S. Basilio sconsigliava l’eremitaggio in favore di una vita più attiva e più vicina ai fedeli in difficoltà. «Il monachesimo bizantino», come lo si dovrebbe chiamare – ha spiegato la storica bizantinista Vera Von Falkenhausen, «non era affatto “basiliano”. Benché i tratti di S. Basilio fossero copiati senza tregua, i canoni della santità monastica si basavano piuttosto sugli ideali eremitici dei padri del deserto e sul modello di S. Antonio Abate, il monaco significava – almeno in teoria – fuggire il mondo con tutti i suoi lussi materiali e intellettuali, ritirarsi nelle zone più remote e inaccessibili e praticare, quasi in gara con gli altri, una ascesi severa. Perciò i monaci greci, anziché missionari cultuali e insegnanti, molto erano umili e ignoranti, mentre quelli colti e sapienti, come S. Basilio, S. Teodoto Studita o anche S. Nilo di Rossano, provenendo da famiglie istruite, avevano goduto di una buona educazione letteraria prima di prendere l’abito monastico.»
La dizione di monachesimo basiliano fu un’invenzione, pare, della cancelleria di papa Innocenzo III (1161-1216) per distinguere i monasteri di rito greco da quelli di rito latino!
Secondo, il monachesimo bizantino non si diffuse nelle nostre zone a causa delle persecuzioni iconoclaste dell’VIII secolo. All’epoca, la Lucania e il nord del Calabria erano in mano dei Longobardi, convertiti al Cristianesimo cattolico (e latino). Solo dopo la riconquista operata dalle truppe dell’imbattibile Niceforo Foca, tra l’880 e l’886, i territori tra il Pollino e la valle del Sinni tornarono sotto l’egida di Costantinopoli. Il potere centrale bizantino invogliò quindi l’immigrazione di monaci di rito greco dalla Sicilia – ormai conquistata dagli Arabi – e dalla Calabria nei territori tolti ai Longobardi, per poter così riaffermare il potere del basileus non solo nella sfera civile, giudiziaria e amministrativa, ma anche in quella religiosa.
Ed è in questo contesto, e in questa epoca, che dobbiamo rintracciare le lontane origini di piccolo romitorio nostrano.
Santa Maria la Laudabile, Santa Maria ad Nives, Madonna dell’Olivo.
La chiesetta è sempre stata, dal momento in cui fu creata, parte della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Nonostante la grande quantità di documenti dell’archivio di quella parrocchia, nelle mie ricerche ho ritrovato poche notizie sull’eremo.
Il primo documento in cui ho trovato qualche notizia è una visita episcopale del 1601, in cui si dice che la chiesetta «supra monte fabricata, habet unu altare cum Imago Beata Verginis […] dicta ecclesia habet una Campana, et una porta bene clave munita.» Forse all’epoca la chiesetta conservava ancora la semplicità dell’impostazione originale. Il documento la chiama però Santa Maria la Laudabile, un nome che – salvo mi sia sfuggito! – sembra essersi da molto tempo perso nella memoria collettiva.
Poco tempo dopo la chiesa fu oggetto di lavori: nella visita del 1603 si dice ora avere «duo altaria in quod maiori celebravit». Nel 1683 la chiesetta appare con il nome popolarmente usato oggi: «Cappellam S. Marie de Oliva, in qua sunt duo altaria [dedicati a] S. Antonÿ, et S. Michealus Arcangeli.» Oltre mezzo secolo dopo, nel 1746, il vescovo visitatore torna nella «Cappella S. Maria Olivarum extra Moenia, filiale ecclesia Archipresbyteralis. In ea sunt tria Altaria», ma il documento non ci dice a chi dedicati.
Anche nei secoli dell’epoca moderna la chiesetta aveva continuato a svolgere la sua funzione di eremo. Monaci, frati, sacerdoti ma anche semplici fedeli la usavano per dedicare tutta o parte della loro vita alla preghiera e alla contemplazione. Nel catasto generale del Regno di Napoli del 1753, studiato per Maratea dal compianto prof. José Cernicchiaro, troviamo che, in quell’anno, il complesso ospitava un «romito» a cui la parrocchia provvedeva di scarpe e abito e pagava «per accomodare la strada […] tre once e dieci grana», oltre che sostenere altre spese per solennizzare la festa del 5 agosto con «candele per la festività, oglio per lampe cha ardono notte e giorno, polvere» e «dieci sacerdoti per celebrare la messa cantata e due chierici».
La quiete ascetica venne scossa nel 1806, quando i soldati al comando del generale Lamarque assediarono il Castello di Maratea difeso dal nostro concittadino Alessandro Mandarini (1762-1820). In questa occasione – episodio poco noto – l’eremita inquilino della chiesetta, Francesco Maimone, frate francescano, venne ucciso dai francesi perché rifiutò di collaborare con i francesi durante l’attacco.
Rovina e ricostruzione.
Successivamente, l’eremo andò in rovina. I tempi erano difficili e le chiese erano state spogliate delle rendite finanziarie con cui si mantenevano. Negli atti della Santa Visita del 1830 la chiesa della Madonna degli Ulivi non appare con nessuno dei suoi nomi: probabilmente era ridotta ad un rudere!
Fu solo grazie al nostro concittadino Giuseppe Ciceraro (1800-1886), cantore della parrocchia di Santa Maria Maggiore e attivissimo nel raccogliere elemosine per restaurare chiese (celebre è il suo attaccamento alla chiesa di S. Anna nel centro storico), che una decina d’anni dopo si riuscì a rimettere in piedi la chiesetta. Ma non furono lavori destinati a durare: altri decenni d’incuria ridussero di nuovo la chiesa a rudere. Finalmente, il 5 agosto 1994 l’eremo veniva restaurato e riaperto al culto.
Tesori di casa nostra.
La chiesetta ha un’unica navata, più lunga che larga. Originariamente doveva essere, quando meno nel presbiterio, ricca di dipinti. Ne sono prova le tracce del Gesù Pantocratore, un dipinto acefalo che si trova nella parte superiore dell’abside; l’immagine di S. Caterina d’Alessandria e quella della Madonna con il Bambino, ben conservate. Tutti questi dipinti sono stati datati, non so quanto correttamente, al XIV-XV sec.
L’altare maggiore è costituito da un grande pezzo di legno ricavato da un’unica radice d’ulivo, da cui il nome popolare di Madonna degli Ulivi per la chiesa. Sull’altare è alloggiata la statua della Madonna della Neve, in legno. Esiste un secondo altare, sulla parte destra della navata, ma il quadro che vi era alloggiato non esiste più.
Da una testimonianza di Carmine Iannini (1774-1835) sappiamo che fino alla prima metà del XIX sec. esisteva ancora in chiesa il quadro fatto fare dopo l’assedio banditesco del 1676, rappresentante «i Banditi, perseguitati da’ Marateoti: S. Biase che gli metteva in fuga; e la Vergine SS.ma che da sopra le nuvole Maratea proteggeva». Questo quadro oggi non si trova più né in altre chiese né – per quanto ne so – presso i magazzini della locale Soprintendenza ai Beni Culturali.
Questa chiesetta sintetizza un po’ tutta la situazione del complesso rapporto di Maratea con il suo patrimonio artistico: c’è, è facile arrivarci, è tutta restaurata ma perché isolata sta chiusa 364 giorni l’anno!
In una grande città d’arte, la chiesetta della Madonna degli Ulivi sarebbe una attrazione secondaria, roba da cultori d’arte bizantina – tre persone su venti, per capirci – probabilmente visitabile solo su appuntamento, in gruppo di almeno quindici persone e con una guida.
Da noi, invece, rappresenta un pezzo della grande carta che finora il turismo marateota non ha saputo giocarsi. Il nostro patrimonio artistico-religioso è senza dubbio di valore riconosciuto, ma finora ha scontato l’handicap di essere frazionato in tanti piccoli episodi – chiese e chiesette – che, come questa, sono difficili da custodire. Ad oggi, tutte le soluzioni pensate, e talvolta messe in pratica, hanno ovviato al problema con lo studio di percorsi/itinerari “religiosi” che permettessero la visita dei luoghi con l’aiuto di guide. Ma hanno sempre fallito.
Troppo male si sposa, infatti, il sostegno di un’invasiva guida/accompagnatore onnipresente tanto con le scarne risorse a disposizione degli enti locali, tanto con la dimensione esperienziale che il turista (giustamente) cerca in luoghi così particolari come quelli offerti da Maratea.
Il nostro patrimonio, così unico nelle sue problematiche, ha probabilmente bisogno di un modello più originale, un vero e proprio modello Maratea nel campo, che riesca a permettere sia il libero usufrutto del luogo da parte del turista sia la sua custodia: una visione che inquadri le chiese di maggior valore artistico del nostro territorio come un grande pinacoteca, frazionata, magari con tanto di giorni e orari di apertura… e no, senza biglietto d’ingresso, perché il volume di denaro mosso da una attrazione culturale – si pensi solo ai servizi connessi – è senza dubbio maggiore quando una parte di esso non viene “immobilizzato” dal costo del biglietto!
Ma per tutto questo si dovrà, forse, aspettare. Intanto, approfittiamo di questa giornata, in cui possiamo andare a sbirciare alcuni dei nostri tesori tenuti sotto chiave…