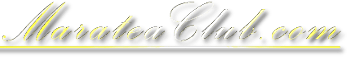Perché a Maratea ci sono cinque cimiteri?
Lo scorso giovedì 31 ottobre la dirigenza dell’I.S.I.S. “Giovanni Paolo II” mi ha dato la possibilità di incontrare gli studenti delle classi 3°, 4° e 5° dei nostri licei per un incontro a tema storico su un argomento… non troppo allegro: Il giorno dei morti e i rituali della Morte.
Avrei voluto replicare l’incontro anche oggi 2 novembre in una delle nostre chiese ma il venir meno di altri relatori mi ha spinto a rinviare ad anni venturi l’occasione.
In ogni caso, come ho promesso a cultori di Storia locale che me lo hanno chiesto, pubblico alcuni dei frutti delle mie ricerche nei nostri archivi sul tema.
Prima dei cimiteri.
Come è ampiamente noto, prima della creazione dei campisanti – i quali sono, va sempre ricordato, una invenzione recente – i defunti della comunità erano tumulati nelle chiese.
Non tutte le chiese erano deputate allo scopo. Nella parrocchia di Maratea Castello le chiese con sepolture erano (almeno) quella di S. Maria Maggiore, che si trovava vicino la porta principale della vecchia città fortificata, quella di S. Nicola, che non ho mai potuto (finora) localizzare nei ruderi, e il Santuario di S. Biagio.
La basilica aveva undici sepolture, otto delle quali appartenenti a famiglie gentilizie. Le restanti tre erano quella dei bambini morti prima dei 7 anni, la sepoltura comune e quella dei sacerdoti. La sepoltura comune era enorme e poté ospitare le ossa di tantissimi nostri antenati perché, quando la si scavò si ruppe la volta di una grotta e quindi, come dice un documento del 1841 trovato nell’archivio comunale, «per costante tradizione dicesi sprofondare in una Caverna interminabile, che niente puol pregiudicare alla salubrità dell’Aria».
La sepoltura dei sacerdoti stava sotto il presbiterio e, durante i lavori del 1940 per lo spostamento della Regia Cappella del santo, don Domenico Damiano (1891-1969) annotò come egli con gli operai «discesi in una specie di antro attraverso una botola, al solo lume della stearica, ci trovammo tra ventiquattro sacerdoti seduti intorno, nell’immobilità silenziosa della morte».
Nella parrocchia di S. Maria Maggiore, invece, non tanto la Chiesa Madre, quanto l’Annunziata era la principale fossa per i defunti. Qui, tra l’altro, le sepolture gentilizie sono facilmente individuabili perché, ancora oggi, sopra i quadri degli altari laterali sono rappresentati gli stemmi delle famiglie a cui appartenevano.
Come erano fatte le sepolture nelle chiese?
Per sopperire alla scarsa quadratura dei piani di calpestio, le sepolture erano progettate per sfruttare le cubature ricavabili nel sottosuolo delle chiese.
Generalmente, le sepolture avevano due piani. Il primo, a cui si accedeva dalle botole del pavimento, era il putridarium o camera di decomposizione. Sì, è esattamente quel che sembra. In questo ambiente, a cui lati c’erano dei sedili con al centro un foro, si mettevano i defunti a scolare: il becchino trafiggeva i cadaveri, avvolti in sudari, così che i liquidi di decomposizione colassero nel foro.
Quel foro, così come la fessura posta al centro dell’ambiente, era l’unica comunicazione con il secondo piano, l’ossario, in cui, una volta scheletrificati i corpi, si buttavano giù le ossa.
Per noi moderni è difficile immaginare l’orrore cui si trovavano di fronte i becchini quando entravano nel putridarium: non ci sorprende, allora, di scoprire dai registri parrocchiali che questi lavoratori erano tra i meglio pagati della comunità…
Il caso degli innamorati di Messina.
Le sepolture gentilizie non erano aperte unicamente ai membri di una determinata famiglia: in caso di parentela – anche lontana – si poteva chiedere la cortesia che un congiunto potesse essere sepolto in una di quelle, così da evitare, almeno per qualche tempo, l’anonima sparizione dei suoi resti dentro un ossario comune.
Anche le persone giuridiche potevano avere una propria sepoltura: è il caso delle congreghe.
Ma anche l’ospedale dei Pellegrini aveva la propria. Questo ospedale, fondato nel 1695 in concomitanza con l’allungamento della festa di maggio di S. Biagio e pensato per dare soccorso ai forestieri che si ammalavano a Maratea, aveva la propria sepoltura sotto l’altare di S. Maria di Costantinopoli nella chiesa dell’Annunziata. L’altare oggi è quello a sinistra entrando, intitolato poi a S. Biagio.
Questa sepoltura cela una triste storia d’amore. Due innamorati di Messina, Anna Starraggi e Antonio Fogliano, erano cugini: per sposarsi dovettero veleggiare fino a Roma, dove ottennero dispensa papale. Sposatisi in Vaticano, tornarono a casa ma, nel viaggio di ritorno, Anna si ammalò e morì nell’ospedale di Maratea il 4 marzo 1740. Per poter un giorno riposare affianco all’amata, Antonio si stabilì a Maratea e qui morì, anni dopo, chiedendo di poter essere sepolto affianco ad Anna!
L’odissea del camposanto di Maratea.
Dopo la conquista francese del Regno di Napoli si promulgò anche nel Mezzogiorno d’Italia una legge per la creazione dei campisanti, luoghi deputati a sostituire le sepolture nelle chiese – considerate antigeniche – e diventare l’unico luogo per la tumulazione o l’inumazione dei morti.
Ma in molti paesi, compresa Maratea, questo passaggio fu una vera e propria odissea.
In un documento dell’archivio comunale del 1829 abbiamo traccia del primo tentativo di costruzione di un camposanto, il cui progetto all’epoca risultava già abbandonato. Nel documento di dice che il «Campo Santo principiato nella Contrada detta Mazzarelle, non è niente adatto, anzi incomodo per questa Popolazione per tanti riflessi, come sono la lontananza di circa due miglia, la strada alpestre, la situazione non Centrale, il terreno ghiaioso, perché sito in un punto dove manca il Sole tre mesi, e quindi non atto a favorire la decomposizione de’ Cadaveri». Il sindaco Donato Marini D’Armenia, allora, proponeva di spostare il progetto. Secondo il sindaco, «il Luogo unicamente adatto, e che offre insieme un risparmio, è quello in contrada nominata S. Giovanni, esistente non molto lungi dall’Abitato in elevato sito, e quindi esposto nella sua isolazione [sic] al soffio di ogni vento, che comunque si scaglia, e da qualunque parte spira, anche in grado fortunale, giammai le esalazioni possono penetrare nel Comune, perché sempre coll’infuori, ed in lontananza di dissipano… considerando [anche] che nella nominata Contrada vi è un’adiacente Cappella eretta sotto lo stesso titolo, che apre al pubblico, al quale appartiene, e che non ha nel suo circuito profondità di terreno, da potersi cavare dalle fossate, che la inumazione impreteribilmente richiede, sia come si sperimenterebbe in ogni altra parte anche più lungi del Territorio, per essere petroso, e quindi povero di terra mobile».
L’idea piacque agli organi amministrativi, ma la spesa per realizzarlo richiese di trovare una sistemazione provvisoria: nel 1839, infatti, erano state chiuse le sepolture delle chiese.
Si scelse allora di utilizzare come camposanto provvisorio la chiesa di S. Francesco di Paola – all’epoca non circondata da case – «la quale contiene sufficiente numero di sepolture, atte a contenere i cadaveri del Comune, ed a supplire al momento per l’oggetto, e sita da circa un quarto di miglio dall’Abitato e nella parte bassa del Paese, in modo di non poter arrecare nocumento veruno alla pubblica salute».
Ciò però provocò le perplessità degli abitanti delle zone più lontane dal paese. Poche settimane dopo, quindi, si deliberò anche «1) che provvisoriamente e fino a quando non va ad aprirsi il Camposanto di questo Comune, che trovasi fin dall’Anno scorso progettato, gli abitanti di Brefaro, Massa e Castello vadino a seppellirsi nella solita Chiesa del Castello medesimo che chiamasi Maratea superiore, luogo quest’ultimo senza abitanti, quantunque sede parrocchiale; 2) che gli abitanti del Villaggio Acquafredda dovessero seppellirsi anche provvisoriamente in quella Chiesa e finché non sarà aperto il succennato Camposanto del Paese in generale; e poiché la strada di Marizzi che in detto Villaggio conduce essendo inaccessibile nella lunghezza di due miglia devesi prima rendere atta al trasporto della Bara, in modo che gli Uomini non andassero soggetti a perdere la vita, essendo situata su perfetto pendio, in un’altezza smisurata del mare sotto della quale va a frangersi».
Ma la famiglia Di Lieto, proprietaria di alcuni fondi intorno la cappella di S. Giovanni, ricorse contro la decisione di costruire lì il camposanto. Secondo la famiglia anche la cappella apparteneva a loro e la decisione del Comune era inapplicabile.
Il Comune cercò di far valere le sue ragioni, ma quando, nel 1840, si fece un sopralluogo a S. Giovanni con un perito – un tal ingegner Dente – si ebbe una sorpresa: il luogo «non può essere addetto a tal uso per essersi rinvenuta dell’Acqua nel fondo, come oculatamente ha osservato il detto Signor Dente, nella cui presenza si è scavato il terreno, ed alla profondità di circa un palmo subito è comparsa l’acqua, ciò che prima non erasi verificato; ed una tal cosa è dipendente dal trovarsi il sito prescelto alla falda del Monte S. Biase, per cui soggetto sempre ad inondarsi».
La situazione cominciò a mostrare tutta la sua drammaticità.
La chiesa di S. Francesco iniziò a riempirsi di cadaveri a un ritmo maggiore di quanto la naturale decomposizione dei corpi permetteva di recuperare spazio. Per cercare di controbilanciare, nel 1843 si decise di permettere ai membri delle congreghe di riprendere a seppellire i propri morti a parte, ognuno nelle chiese dove avevano sede.
Le sepolture gentilizie vennero sequestrate, anche per evitare le ambigue situazioni in cui certe famiglie provavano a vendere le proprie sepolture al Comune, conoscendo la situazione di bisogno.
Nel 1846 la chiesa di S. Francesco venne chiusa al culto. Anche la statua del santo di Paola dovette essere trasferita. Non si riusciva più a entrare stante «l’insoffribile puzzore che sentesi». La situazione stava sfuggendo di mano, anche perché particolari cittadini, per dare sepoltura ai propri defunti, avevano «rotto e scavato il pavimento in vari punti, ed ivi indecentemente si pratica l’inumazione de’ Cadaveri colla copertura di poca terra e calce».
Rifiutando le proposte degli organi superiori di costruire un camposanto per inumazione a La Moneca o in altri punti della valle, il Comune di Maratea insistette più volte, a questo punto, per trasformare la parte intanto crollata dell’ex convento dei Paolotti (di cui la chiesa di S. Francesco faceva parte) in un camposanto per tumulazione.
Il braccio di ferro non si risolse mai, costringendo il Comune a decidere «che urgentemente dovesse aprirsi una Sepoltura per ogni Chiesa del Comune pel seppellimento de’ Cadaveri, e ciò finché vanno a principiarsi i lavori del nuovo Camposanto, non essendovi altro mezzo con cui poter dar riparo all’imperiosa Circostanza». Una delle chiese più sfruttate in questo senso fu S. Vito, adatta perché isolata.
Nel 1856 venne anche autorizzata la costruzione di una sepoltura nella chiesa di Cersuta, che ne era priva.
Gli attuali cimiteri di Maratea.
Dopo l’Unità nazionale, verso il 1870 si riprese in mano la situazione, intanto immutata.
Nel 1878 si individuò come luogo più adatto per il camposanto un terreno di proprietà del sig. Biasantonio Napoli in contrada La Moneca. Venne acquistato dal Comune nel 1879 per 4.337 lire.
L’appalto dei lavori venne chiuso nel 1881 e il 3 febbraio 1888 il cimitero ospitò il primo defunto, l’ottuagenario Francesco Panza.
Restava risolvere un problema per nulla secondario però: come sarebbero arrivati i corpi dei defunti al nuovo cimitero da Acquafredda o da Castrocucco, dal Porto o da Brefaro?
All’epoca il territorio di Maratea aveva solo tre strade carrabili: la Provinciale Tirrena verso Trecchina, la vecchia comunale verso il Porto, non in ottimo stato, e il tronco di strada comunale verso Acquafredda, che di fatto si arrestava a Cersuta.
Poiché le capacità dell’epoca facevano sì che costasse meno immaginare la costruzione di altri cimiteri piuttosto che di nuove strade, si andò verso la polverizzazione dei luoghi di sepoltura.
Ecco allora che nel 1901 si iniziò la costruzione del camposanto di Acquafredda, nel 1913 quello di Cersuta e nel 1921 quello di Marina, quest’ultimo soppresso e ricostruito in altro sito nel 1957. Ultimo ad arrivare, qualche anno dopo, quello di Massa-S. Caterina.
Il numero di cimiteri di Maratea, strano a trovarsi in un comune di 5mila anime, è quindi spiegato dalle contingenze di epoche passate in cui la carenza di finanze veniva controbilanciata dalla popolare Pietà e attivo civismo.